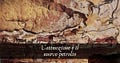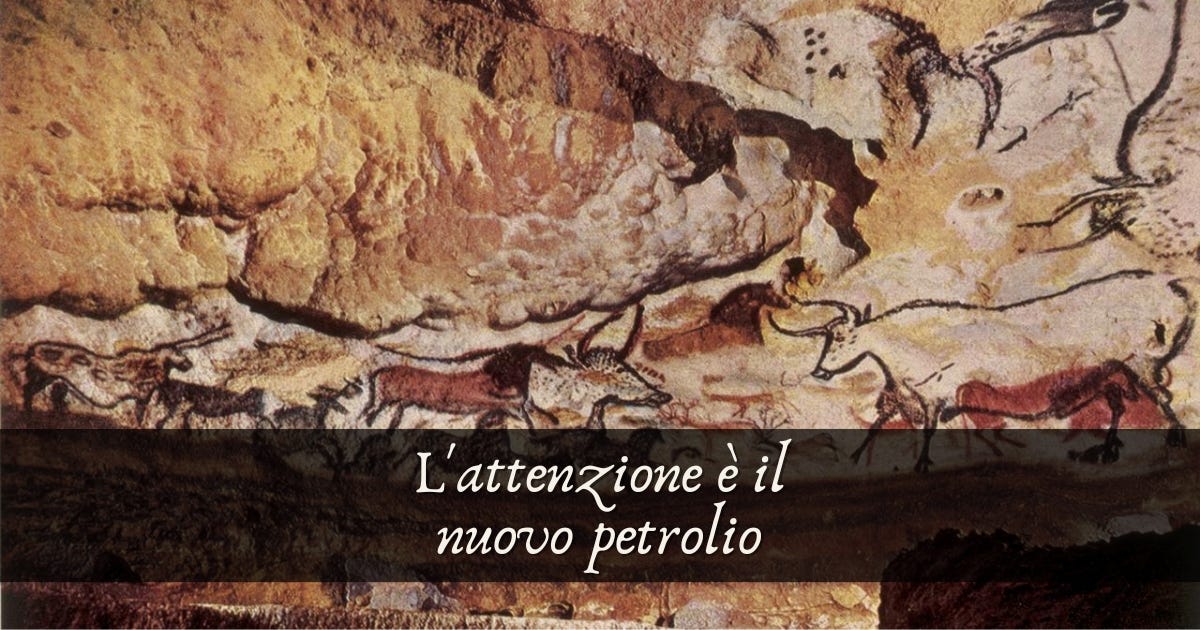Ascoltami molto bene
Se le economie sono definite dalla scarsità e non dall'abbondanza, in un'epoca di sovrabbondanza di informazioni, che cos’è scarso? L'attenzione.
In quale momento storico ti piacerebbe andare, se potessi viaggiare nel tempo?Quando me lo chiedono, rispondo che sicuramente vorrei partire dal Neolitico, circa 17.000 anni fa, insieme ai cacciatori raccoglitori che vivevano nei pressi delle Grotte di Lascaux.
Dopo una giornata di raccolta di frutta e bacche o di una fortunata caccia all’uro, non vedrei l’ora di sedermi all’imbrunire, scorgendo gli ultimi riflessi rosa dei raggi solari sopra immensi banchi di nuvole bianche. Sotto quelle grotte, accucciato intorno tepore di un fuoco scoppiettante avrei ascoltato per ore i racconti mitici dell’uomo più anziano del mio clan con il volto dipinto di rosso. Giganti tori che saltano irrefrenabilmente scuotendo la terra, aquile maestose che squarciano il cielo causando la pioggia, querce così grandi da oscurare il mondo in una notte senza fine, donne così fertili da generare figlie già incinte per evitare l’estinzione della tribù.
Immagino quelle soste interminabili di silenzio assorto, mentre le parole lente e onomatopeiche vengono scolpite nella memoria collettiva del gruppo, per essere tramandate ancora, e ancora. L’uomo anziano è seduto su un piccolo piedistallo di pietra, gli uomini sono accanto a lui quasi dovessero assorbire nella loro carne le storie appena evase dalla memoria del saggio, le donne, con i piccoli accoccolati nelle loro gambe, sono vicine al fuoco per riscaldare la pelle e il cuore.
Come un totem iridescente, la fiamma occupa il centro dello spazio: essa è al tempo stesso luce, calore, energia, proiettore magico dei racconti mitici sulle pareti della grotta, dove a ognuno di noi sembra di scorgere quel toro che salta, o le enormi ali dell’aquila spalancate in un cielo giallo.
Perché sono partito da un volo così lontano nel passato? Perché, come affermava Philippe Daverio, in non-ricordo-più-quale-puntata di Passepartout, gli homo sapiens, dal Paleolitico alla Televisione, sono cambiati tutto sommato piuttosto poco. Che cos’era, ancora, la televisione, se non un focolaio familiare condiviso attorno al quale ascoltare storie e miti collettivi?
Per quasi tutta la totalità della nostra storia di esseri umani, abbiamo vissuto i momenti liberi dal lavoro intorno a un fuoco (reale o metaforico), dagli Assiri agli Aztechi, dai cortigiani di Carlo Magno alla famiglia imperiale della dinastia Ming, dai ghibellini ai girondini e ai montagnardi, raccontandoci racconti, condividendo informazioni, segreti e ambasciate, scambiando consigli o persi nei pettegolezzi sulle figlie del vicino. Per quanto una persona fosse erudita o potente, l’accesso alle informazioni era limitato e ristretto alla sua comunità, oltre che essere notevolmente diluito nel tempo.
Si ritiene infatti che un intellettuale del sedicesimo secolo potesse incamerare, nell’arco di una vita intera, circa 80GB di informazioni. Oggi l'uomo medio ne assorbe la stessa quantità, ogni giorno.
Per questo motivo, fino a pochi anni fa si parlava di economia dell'informazione: perché si trattava di un bene scarso e costoso. Pensa quanto doveva costare l’informazione pervenuta dall’ambasciatore veneziano a Costantinopoli durante la battaglia di Lepanto, o quanto fosse prezioso un prelato di campagna che sapeva a memoria quasi tutta la Bibbia.
Poi è arrivata l’internet, che ha cambiato tutto, tanto da poter essere paragonata a una nuova scoperta del fuoco, perché ha divorato il paradigma di fruizione delle informazioni ridefinendone completamente le regole.
Oggi le informazioni sono potenzialmente infinite e immediatamente accessibili, oltre che in sovrapposizione tra loro. Siamo diventati infobesi.
Quindi, se le economie sono definite dalla scarsità e non dall'abbondanza (perché è la scarsità che definisce il valore), in un'epoca di sovrabbondanza di informazioni, che cos’è scarso? L'attenzione.
Per buona parte del secolo scorso il bene più importante è stato il petrolio, per cui si sono combattute guerre e attorno al quale sono state definite le gerarchie del potere mondiale. Oggi, invece, il bene più importante è l’attenzione, il nuovo petrolio.
L’oro nero era stato elevato al trono dall’invenzione del motore a combustione, dalla seconda rivoluzione industriale e dall’accresciuto bisogno di mobilità per l’interconnessione delle nostre società. Nella nostra epoca, invece, la transizione digitale ha trasferito i pozzi di estrazione della ricchezza sugli smartphone nelle nostre tasche, nei cruscotti delle auto, nello speaker accanto al microonde, perforando giorno e notte, alla ricerca della nostra attenzione.
Non a caso, quattro delle prime cinque più grandi aziende al mondo sono “fabbriche di contenitori di attenzione”: Apple, Microsoft, Alphabet (Google) e Amazon. Una sola, la Saudi Aramco, è ancora legata al petrolio.
La nostra attenzione è il nuovo combustibile che move il mondo, alimenta i mercati, sovverte i governi, glorifica nuove divinità e mette al rogo gli eretici, in un catena senza fine di proposte e controproposte.
Se fino a poche decine di anni fa i nuclei familiari si riunivano attorno alle stesse trasmissioni televisive serali, oggi ognuno di noi può switchare tra una diretta Instagram e un video YouTube, tra un livestream su Twitch e una serie su Netflix, o su Prime, NowTV o DisneyPlus, magari scrollando con la mano sinistra l’infinito loop di TikTok, mentre con il telecomando nella destra sceglie cosa vedere sulla SmartTV o sul tablet, in un infinito presente, come ne ho parlato in quest’altro numero di Trasumanare.
Come nel ‘900 si sviluppavano nuove armi intelligenti per conquistare l’accesso al petrolio, oggi i riflettori sono puntati sulla ricerca dei migliori algoritmi in grado di estrarre la maggiore attenzione possibile da ciascun utente.
I social media (anche se le nuove app vengono definite più propriamente suggested media, in quanto non è più necessario seguire i contenuti della propria rete sociale, ma basta ricevere i suggerimenti della piattaforma, uno su tutti, TikTok), sono riusciti in un’impresa sorprendente: generare infinito valore dai contenuti versati nell’imbuto mediatico dai loro stessi utenti, che sono al contempo produttori e fruitori di contenuti.
I post, i reel, i commenti, le incazzature, la follia che si scatena globalmente e in ogni istante sono elementi che producono attenzione dal prodotto stesso dell’attenzione. Come se la Eni riuscisse a produrre eroina dai gas di scarico delle auto.
Alla luce di questa nuova consapevolezza, come ho già scritto in un numero sul paradosso dell’abbondanza, quando scegli su quale piattaforma rivolgere la tua attenzione, immagina che in quel momento stai collegando una pompa di estrazione petrolifera al tuo cervello e stai concedendo la risorsa più preziosa della nostra epoca al proprietario di quella piattaforma.
Vale davvero la pena quell’ora di scrolling con video di gattini o la maratona della serie con la ragazza americana che si trasferisce a Parigi, la chat di quel gruppo crypto su Discord, la lettura di quel thread su Twitter o di questa stessa newsletter?
Non c’è nulla di sbagliato a priori, nulla di corretto a priori. L’unico consiglio che mi sento di darti è di riflettere adeguatamente sul valore della tua attenzione e su chi sta ricevendo quella risorsa. Ingozzarti quotidianamente di spazzatura informativa, sul tuo cervello ha le stesse conseguenze deleterie che avrebbe sulla tua salute il mangiare tutti i giorni un panino dal porcaro in tangenziale.
Scegli con cura le tue fonti di racconti e informazione, in modo che siano nutrienti e sane per la tua mente. Ogni tanto va anche bene mangiare il kebab su TikTok, ma cerca di mantenere una dieta digitale equilibrata.
Per concludere, ringrazio tutte le persone che decidono di dedicare il loro tempo prezioso a questa newsletter e che mi condividono con entusiasmo. Gli ultimi 3 numeri hanno superato il 70% di apertura, una percentuale veramente altissima che mi stimola a fare sempre meglio.
Consigli di lettura
Perché diciamo che ci manca il tempo - ITA
E se l’amore fosse un luogo? - ITA
Tutto è uno. La fisica quantistica sembra confermare la corrente filosofica del monismo. Sulla struttura infinitesimale e unitaria dell’universo - ENG
Cinque consigli che ti semplificano la vita - VIDEO
Le immagini del profilo non sono più cool. - ENG